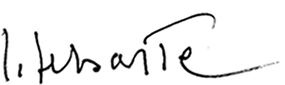Elisabetta Pozzetti, dal catalogo “L’Alchimia della metamorfosi”, 2003
Da granello di pigmento osservavo l’affaccendarsi dell’artista, che armeggiava con pennelli e spatola, ingaggiando con le mani una sfiancante lotta tra i mille schizzi, ritagli e cataloghi che riposavano alla polvere dei giorni. Sbirciava tra le tele che, in ordinata e silenziosa rassegna, sfilavano una appresso all’altra contro la parete. Alcune erano ormai anni che non le sfiorava la luce di uno sguardo. Quelle libere dai vincoli del robusto telaio se ne stavano comodamente arrotolate sulla mensola, proprio sopra lo stereo che amplificava le note di Vivaldi. La mattina cresceva e dalle ampie finestre di nuovo chiarore si vestivano le superfici. Il signore delle cromie era lui. Salvatore, sì quello era il suo nome, lo stesso sentito sussurrare con dolcezza, strapazzare con rabbia, sfilacciare in monosillabi di comprensione da Iolanda, fedele anima e spirito complice di quell’uomo cresciuto all’arte. Si muoveva sicuro nell’ampia stanza satura di umori, cercando l’ispirazione, che se ne stava nascosta sotto un vecchio cartone ondulato. Fui io, piccola particella di colore, scivolata dalle ruvide setole di un pennello dismesso, ad attirare il suo occhio attento sul tavolo. Si illuminò il volto e un sorriso sornione abbracciò il fantasma dell’opera in divenire. L’alchimia della metamorfosi eccitò i barattoli di acrilico, i fustini di colla vinilica, mentre i tubetti si agitavano nelle confezioni. Le carte bisbigliavano spingendosi nel gareggiare a farsi notare. Ma la mano poderosa e sensibile afferrò il vetusto cartoncino deformato dal tempo. Iniziò qui la storia di una ricerca che ancor non placa l’entusiasmo. Che diviene parte integrante e sostanziale dello stratificarsi materico delle creazioni di Sebaste. E, come nelle ridotte dimensioni il lavoro è di fine cesellatura, così nelle grandi estensioni la forza gestuale manifesta la massima intensificazione. Il supporto si tende a semplice tela di fitta tramatura, di cui niente trapela nell’elaborazione finita dell’opera. E’ cioè semplice elemento strutturale senza alcuna finalità estetica. Con generosa distensione accoglie gli strati di materia in succedersi pianificato. I frammenti di cartone e di sughero sono i primi ad esplorare la superficie e a adagiarvisi sopra, come pronunciate sagome, ritagliate ed elaborate, che osano oltre i limiti del telaio. In Salvatore osare implica il forzare l’essenza dei materiali, metterli alla prova e sfruttarli per usi non previsti all’origine. Saggiarne le proprietà sconosciute e forgiarne di nuove. La spatola distribuisce costrutti espressivi stendendo un impasto di pigmento e collante, isolando le parti aggettanti. Il nuovo strato si predispone ad accogliere la sabbia, che piove copiosa dal setaccio, disegnando granulosi tracciati di pensiero che si assottigliano a fil d’ombra, fino a scomparire. Interrogative si appuntano le virgole di colore spremute direttamente dal tubetto, ora in punti isolati ora tracciando inusitate geografie di spazio, in musicale equilibrio. Coglie impreparati la colata di colla, che Salvatore dirige con ampia distensione del braccio orchestrando i ritmi cromatici e spaziali, fluendo sottili ragnatele fino a addensamenti lavici dal biancore latteo. La gradina pettina le rughe della superficie muovendo ulteriormente l’andamento lineare. L’interazione massima dell’uomo con la materia si ottiene però solo successivamente, quando gli strati vengono provocati, provati e purificati. Se il fuoco rappresenta distruzione, in Sebaste è processo catartico di elaborazione artistica: bruciando svanisce l’effimera patina ed emerge l’epidermide nascosta. Mentre la colla ribolle, sbuffando in smorfie di stupore, il sughero annerisce grumoso e risentito, mentre il cartone si sfoglia rivelando l’interna anima di ondulato sostegno. Tenace la lingua di cromo non scompare, si satura solamente. Crateri lunari affiorano, mentre il pennello e le mani asportano energicamente i relitti degli strati sfatti alla fiamma. L’armonia è ora alterata dal nero, memore della ferita inferta. A placare la dissonanza tra l’essere originario e il divenire, interviene un ulteriore strato liquido che rimargina le bruciature, colma i vuoti e addolcisce le asperità. E’ lattiginoso ed è una miscela di collante e acrilico in medium acquoso. Perché questa ulteriore pellicola? Per fissare la mutazione avvenuta, separando l’antica materia alla nuova, sublimata. E anche perché Sebaste attutisce la variante cromatica, favorendo la dominante materica varia e diversificata. Non gli interessano cioè i differenti colori ma le diverse modalità di pasta, ora liscia ora raggrumata, scabra o rugosa. Lo spessore subisce e interloquisce, pulsa e soggiace al silenzio della stasi. In esso si struttura il racconto di Sebaste, la storia, cioè, di un’indefessa sperimentazione mai paga di facili approdi, articolata in felici intuizioni e in elaborazioni ardite, contraddistinta da un elemento dominante: la curiosità.