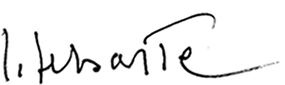Loretta Fabrizi, Dal bianco al bianco, 2003
A partire dal Quadrato bianco su fondo bianco di Kazimir Malevic, esposto a Mosca nel 1919, in cui di fatto viene azzerata la pittura come impresa chiaroscurale, cromatica, plastica, la stesura monocroma che satura la superficie del quadro, nella rinuncia alla funzione descrittiva come a quella espressiva, e nella riduzione al minimo dell’elaborazione artistica, ha rappresentato nell’arte moderna e contemporanea l’affrancamento dell’artista dal sistema della rappresentazione e il confronto con ciò che integralmente trascende la realtà fenomenica.
Il bianco, “il nulla prima della nascita”, e il nero, “il nulla dopo la morte”, come li aveva definiti Kandinski, per la loro stessa natura di compresenza/assenza di tutti i colori, hanno assolto a questa funzione simbolica di riassumere e superare ogni relatività e indicare l’assoluto: icone contemporanee che collegano l’uniforme fondo dorato senza spazio né tempo, immateriale, della pittura bizantina, alla simbologia della luce del mondo gotico, alla luce della costruzione dello spazio in Piero della Francesca, fino All’”infinto suprematista” di Malevic. Da qui una serie di ricerche pittoriche di fondamentale importanza per l’arte contemporanea, volte a rifondare una possibilità per la pittura di fare esperienza del non detto-non scritto-non rappresentato , in quanto oltre noi stessi.
In questo filone di ricerca, come è noto, un ruolo chiave hanno avuto artisti del calibro di Ad Reinhardt, Piero Manzoni, Yves Klein, Lucio Fontana.
Ma se il monocromo è “strumento di arricchimento sensoriale, in quanto esperienza di una sensibilità pura e immateriale, lungi dal ritrarsi dal mondo, non può che aprirsi al mondo per -impregnarlo-” (Giorgio Verzotti). L’ascesa si converte così in una ridiscesa verso gli oggetti, le cose e gli esseri del mondo, lo spazio del mondo, come in Fontana i cui buchi-tagli-squarci indicano, appunto, tanto una dimensione cosmica quanto un’idea di spazio che si identifica con quello reale; l’altrove si lega alla fenomenologia del gesto, all’hic et nunc della spazio e del tempo dell’artista, e di noi osservatori che di volta in volta ne veniamo in contatto attraverso l’opera.
Non deve sorprendere, allora, come il monocromo, nello specifico bianco, si presti ad essere uno strumento efficacissimo di riconquista formale - si pensi a Burri - di risalita, dopo la tabula rasa, verso la possibilità di inedite configurazioni formali: nel rapporto tra figura e sfondo, nella giurisdizione spaziale, nella traduzione del ritmo, nella resa dei valori di profondità, superficie e, perfino, cromatici se anche il bianco può presentarsi con varie sfumature - calce, gesso, alabastro, latte, avorio, argento, roseo, cilestrino – e se, come diceva Leonardo, “il bianco non ha per sé colore, ma si tignie e trasmuta in parte del colore che gli è obbietto”.
Guardando a Prampolini e a Burri, ma anche alla pittura del segno e del gesto tanto americana quanto europea, a partire dagli anni Ottanta, Salvatore Sebaste, avvia uno stile sostanzialmente basato sulla poetica della materia di chiara ascendenza informale: una materia densa di stratificati vissuti che pro-voca l’azione dell’artista a rianimarne le potenzialità inespresse, a risvegliarne le sopite memorie. Sono “palpiti di luce, buttate di colore, suoni di flauti e sibili di vento, fruscii di erbe e frinire di cicale, trascorrere di sogni e pulsare di vita” (Claudio Spadoni) in cui la vitalità intrinseca e incoercibile della materia si fonde con l’esigenza di struttura e di dinamismo formale. Cartapeste acciaccate e sofferte su fondi sabbiosi mettono in scena una danza rituale, arcaica e moderna a un tempo, che a colpi di bianco su bianco attinge ad un “fondo” arcano e misterioso, ma sempre disponibile a svelarsi da cui affiora l’invisibile. Sicché ogni tela bianca è veramente “abbagliante d’attesa”, secondo la suggestiva affermazione di Kandinski.